 Dato che Gesù ha chiamato i sui discepoli e li ha iniziati a seguirlo nella sua vita in una forma totalmente personale non possiamo partire da una storia di Gesù nella quale non si includa la storia della salvezza dell’umanità. Questo perché nei Vangeli la relazione fra la figura dell’oggetto con la risposta del soggetto è così intimamente legata l’una all’altra che non si può separare.
Dato che Gesù ha chiamato i sui discepoli e li ha iniziati a seguirlo nella sua vita in una forma totalmente personale non possiamo partire da una storia di Gesù nella quale non si includa la storia della salvezza dell’umanità. Questo perché nei Vangeli la relazione fra la figura dell’oggetto con la risposta del soggetto è così intimamente legata l’una all’altra che non si può separare.
Vediamo adesso i grandi titoli cristologici che danno una certa risposta alla domanda: «E voi, chi dite che io sia?».
a) Messia-Cristo
Il titolo di Messia aveva nell’Antico Testamento una grande connotazione politica perché significava l’unto (l’eletto da Dio) della casa di Davide che doveva governare il popolo di Dio come Re. Questo modo politico di vedere Gesù con questa definizione per così dire terrestre di Messia era utilizzata dai discepoli – Gesù non ha mai utilizzato il titolo di «Messia» – tra i quali Pietro, in modo da pensare che Gesù sarebbe diventato un Re per salvare Israele dai Romani oppressori e così ritornare al grande regno davidico di una volta. Questa visione politica di Gesù sarebbe la ragione per la quale Egli «impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno» dopo la confessione di Pietro che affermava: «tu sei il Messia» (Mc 8,29). È interessante notare comunque che con questa confessione forse Pietro incominciava a vedere Gesù con gli occhi della fede ma non ancora tutti gli altri discepoli e allora è per questo che Gesù doveva rispondere così a loro di non dire nulla a nessuno.
Gli studiosi come quelli della Third Quest rinnovano la fiducia nel titolo di Messia per la persona di Gesù, quando sottolineano il titolo scritto sulla croce: «Gesù di Nazareth, re dei Giudei». Sarebbe una comprensione globale di Gesù come «Messia crocifisso» per dare una plausibilità storica alle Sue parole e alla Sua vita. Ormai sulla croce non c’è più ambiguità, il Crocifisso che regna soltanto «dal legno» è il vero trono del «Messia-re».
Il termine «Messia» proviene dell’ebraico mashiah e significa «unto». Nella lingua greca si traduce con Christòs, da cui proviene la parola Cristo. Colui che è unto ha un particolare compito da svolgere. Davide era un messia, cioè un unto, il quale doveva mantenere l’unità del popolo e guidarlo verso Dio, con la caduta del regno e tutte le vicende politiche già espresse, il termine designò la speranza di un liberatore, di un discendente di Davide che potesse ridare al popolo una nuova era. Quando comparve sulla scena Gesù di Nazareth, alla figura del Messia era attribuito con una certa ambiguità; sia un significato politico sia spirituale in modo che prima della Pasqua Gesù era visto come capo politico piuttosto che come capo religioso.
b) Figlio dell’uomo
È senza dubbio il titolo più discusso e che è stato predominante negli studi della New Quest. È un titolo che non si presenta come un titolo confessionale e designa l’uomo o un uomo che appartiene alla specie umana. L’espressione «Figlio dell’uomo» in ebraico o aramaico del tempo di Gesù voleva dire «uomo». Ernst Käsemann, lavorando nel 1954 con la New Quest su ciò che sarebbe storicamente accertabile sulla persona di Gesù, dice che non è plausibile dare una definizione a un titolo che non è plausibile in un contesto Giudaico o Cristiano del primo secolo. Soltanto più tardi, con la ricerca della Third Quest sulla storicità di Gesù iniziata negli anni ‘80 si è iniziato a mettere in questione la validità dei criteri della New Quest, tanto che oggi, alcuni membri della Third Quest hanno aderito alla proposta di G. Theissen dando a Gesù il titolo di «Figlio dell’uomo» in un senso «messianico» di salvatore e redentore.
La maggioranza delle volte questa espressione è utilizzata da Gesù (82 volte), ma viene usato anche da altri e nel Antico Testamento come nel libro di Daniele (Dn 7,11-14) dove viene usato per suscitare la speranza che Dio avrebbe salvato il suo popolo. Nel periodo in cui Daniele scriveva, molte erano le persecuzioni e perciò egli annunciava: «il Figlio dell’uomo» verrà «alla fine dei tempi» come giudice per riscattare e liberare il popolo. Essere giudice significa avere potere, e Gesù lo manifesta con le sue azioni: compie i miracoli e perdona i peccati. Gesù parla di sé come Figlio dell’uomo in un senso virtuale o germinale perché con tale espressione evita che la sua missione sia confusa con quella di un liberatore politico.
c) Figlio
Normalmente, si afferma che la possibilità che Gesù si riferisca a se stesso come «il Figlio» o «il Figlio di Dio», nel senso di messia o redentore, normalmente sia da escludere. Tuttavia, la scoperta di un testo aramaico di Qumran che utilizza l’immagine misterioso di «Figlio di Dio» in un contesto escatologico, ha riaperto la questione.
È possibile che Gesù parlasse di se stesso come del «Figlio» in una relazione speciale con Dio, il Padre-Abbá.
Le azioni e le parole di Gesù segnarono il corso di una nuova storia. Gesù si poneva con continuità con quanto era già stato annunciato nell’Antico Testamento, ma in lui si realizzava l’Alleanza nuova, quella definitiva, annunciata dai profeti. Egli dichiarava apertamente di essere il Messia, colui che realizza le promesse dell’Antico Testamento e che mostra agli uomini il volto di Dio. La presentazione di Gesù nella storia viene chiamata «incarnazione». Il nascere di Gesù dalla vergine Maria, il suo divenire uomo, manifesta l’amore di Dio che salva. Gesù non è diventato Dio durante la sua vita o nel momento della sua risurrezione; egli era già Dio prima di essere concepito. Prima della sua incarnazione, potremmo dire che non si chiamava Gesù. Con Gesù il nome «figlio di Dio» entra nella storia. Gesù di Nazareth, nella sua vita terrena, ha mostrato di essere il figlio di Dio.
d) Signore
Nei vangeli e negli Atti c’è un’evoluzione nell’uso della parola «signore» con riferimento a Gesù. Al inizio della vita di Gesù si utilizza questa parola come un trattamento di cortesia per usarlo, dopo la Pasqua, come un titolo di maestà. All’inizio possiamo dire che il titolo «signore» è utilizzato dai discepoli per parlare del «signore» come un rabbi e dopo la pasqua per rendere culto al «Signore» visto come il risorto.
L’insegnamento e le azioni di Gesù suscitano meraviglia, ma anche molti interrogativi misti a incredulità. Ai suoi cittadini Gesù non dava segni: i miracoli non possono accadere se non vi è la disponibilità ad aprirsi a Dio.
Pe. François Bandet
BANDET, François. Il mysterium Christi: Elaborato sulla tesi No 8. (La credibilità della rivelazione cristiana – Prof. Rev. Dr. Salvador Pié-Ninot). Gregoriana. 25 mag. 2008
 I segni sono parte della strada che l’uomo deve seguire per capire il cammino da percorrere, per comunicare con gli altri, e, soprattutto, per avere accesso alla divina rivelazione di Dio. I segni sono, per natura, misteriosi, e, spesso, sono codificati, e si rivelano sempre necessari per trasmettere un messaggio, nell’ambito di una comunicazione, sia umana che divina. Gli eventi concreti che ci offrono un punto di riferimento per accogliere la comunicazione e la manifestazione di Dio agli uomini sono i segni della divina Rivelazione.
I segni sono parte della strada che l’uomo deve seguire per capire il cammino da percorrere, per comunicare con gli altri, e, soprattutto, per avere accesso alla divina rivelazione di Dio. I segni sono, per natura, misteriosi, e, spesso, sono codificati, e si rivelano sempre necessari per trasmettere un messaggio, nell’ambito di una comunicazione, sia umana che divina. Gli eventi concreti che ci offrono un punto di riferimento per accogliere la comunicazione e la manifestazione di Dio agli uomini sono i segni della divina Rivelazione.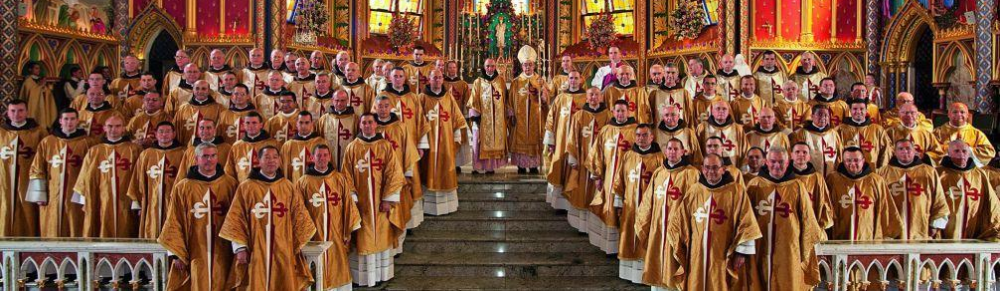
 Pe. Eduardo Caballero, EP
Pe. Eduardo Caballero, EP Dato che Gesù ha chiamato i sui discepoli e li ha iniziati a seguirlo nella sua vita in una forma totalmente personale non possiamo partire da una storia di Gesù nella quale non si includa la storia della salvezza dell’umanità. Questo perché nei Vangeli la relazione fra la figura dell’oggetto con la risposta del soggetto è così intimamente legata l’una all’altra che non si può separare.
Dato che Gesù ha chiamato i sui discepoli e li ha iniziati a seguirlo nella sua vita in una forma totalmente personale non possiamo partire da una storia di Gesù nella quale non si includa la storia della salvezza dell’umanità. Questo perché nei Vangeli la relazione fra la figura dell’oggetto con la risposta del soggetto è così intimamente legata l’una all’altra che non si può separare.